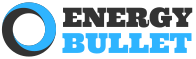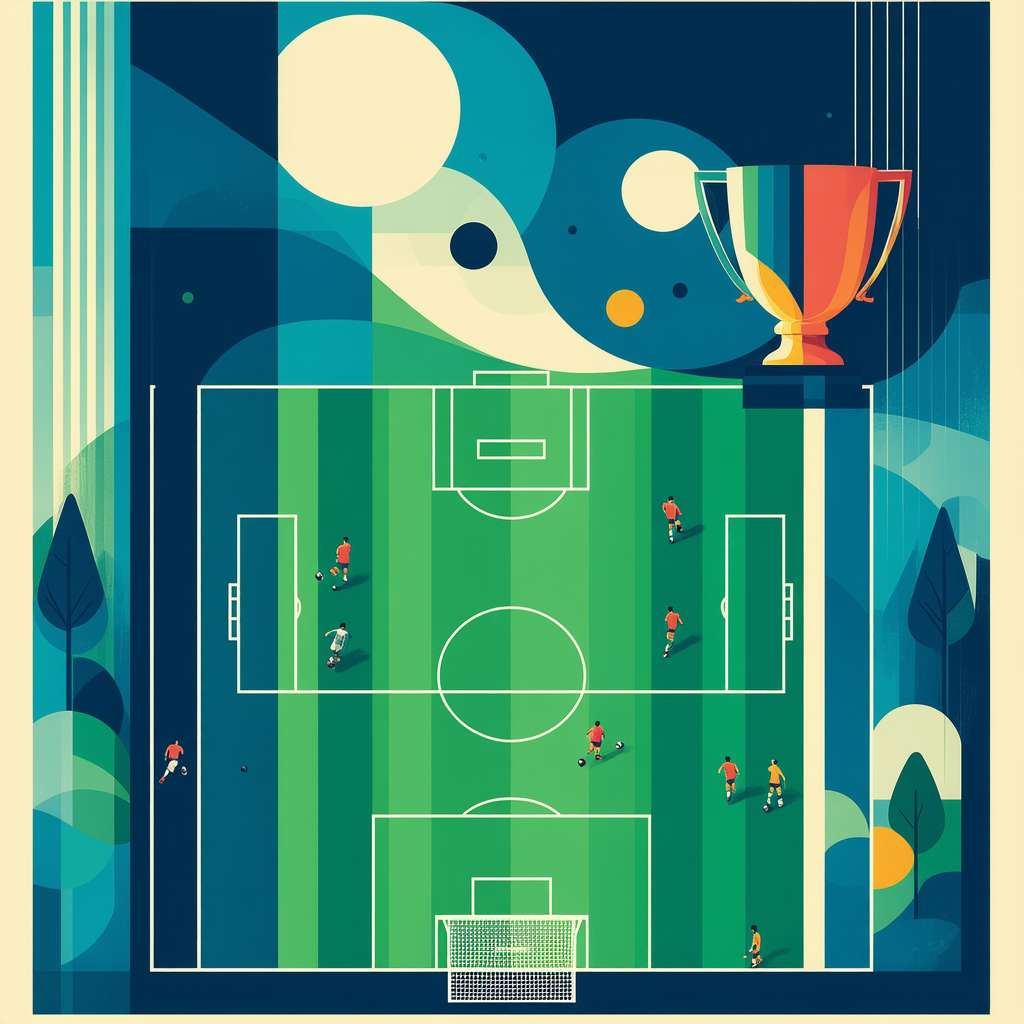E-Mail: [email protected]
- Persi oltre 21 ettari al giorno nell'ultimo anno.
- Spesi oltre 20 miliardi di euro dal 2006.
- Aumento del 10,2% del consumo rispetto al 2022.
L’inarrestabile avanzata del consumo di suolo in Italia
L’Italia si trova ad affrontare una crisi latente ma estremamente perniciosa: quella relativa al consumo del territorio agricolo. Nel corso dell’ultimo anno trascorso, le statistiche indicano che sono andati perduti oltre 21 ettari quotidiani, evidenziando così il massimo livello registrato nell’arco degli undici anni passati. Tale fenomeno non deve essere considerato solamente in termini quantitativi; si tratta piuttosto di un autentico detrimento sia per l’ambiente sia per le finanze nazionali.
Il terreno ricopre ruoli fondamentali nella nostra esistenza quotidiana: modula i microclimi locali, regola i flussi idrici ed è alla base della produzione alimentare oltre a fungere da deposito naturale di anidride carbonica (CO2). La riduzione della superficie terrestre comporta oneri significativi; a partire dal 2006 siamo incorsi in spese superiori ai 20 miliardi di euro, destinate alla sostituzione dei servizi ecologici precedentemente assicurati dai terreni agricoli stessi. Le previsioni future appaiono ancor più fosche; si parla infatti di oneri stimabili intorno ai 9 miliardi annui relativi a questa problematica crescente.
In Italia questo impoverimento territoriale assume caratteristiche ancor più gravi considerata la vulnerabilità geo-idrologica cui già è soggetta la nazione stessa. Riferendosi agli ultimi dati offerti dal rapporto redatto dall’Ispra insieme al Snpa nel corso del 2022, abbiamo assistito a una sottrazione pari a 76,8 km² di terreno utile rispetto all’anno precedente, con uno slancio positivo stimabile attorno al 10,2%. Questo significa che stiamo perdendo una risorsa fragile e limitata a un ritmo insostenibile.
Le cause del consumo di suolo: non solo cemento
Il termine consumo di suolo fa riferimento alla perdita parziale o permanente delle terre dedicate a funzioni vitali quali quelle agricole o naturali. Questo fenomeno ha come motore principale l’artificializzazione della superficie terrestre, che comprende la creazione incessante di nuove strutture edilizie ed infrastrutture necessarie allo sviluppo urbano. Nonostante ciò non si deve pensare che il problema derivi soltanto dall’espansione dei centri abitati.
Le modalità di agricoltura intensiva giocano un ruolo cruciale nel deterioramento qualitativo del terreno sotto vari aspetti: fisici, chimici e biologici; così come lo fanno anche le attività estrattive attuate nelle cave e nelle miniere.
Gli effetti derivanti dal “consumo” dei terreni sono numerosi e profondamente inquietanti: prima tra tutti l’impermeabilità della terra, determinata dalla cementificazione che ostacola l’assorbimento dell’acqua nel sottosuolo; tale condizione incrementa significativamente i rischi connessi ad eventi calamitosi quali alluvioni e frane di indiscutibile portata distruttiva. Si ricorda in questo senso la recente calamità verificatasi in Emilia Romagna caratterizzata proprio da livelli massimi di consumo del territorio.
In aggiunta a tali criticità c’è inoltre un ulteriore aspetto spesso trascurato: quello relativo alla proliferazione disordinata di nuove residenze insediate nei contesti agricoli, ognuno ambiente naturalmente pregiato. All’interno di una situazione caratterizzata da un declino demografico, una considerevole quantità di abitazioni si trova a fronteggiare il pericolo di restare disabitate, con la conseguenza che potrebbero deteriorarsi fino a diventare veri e propri ruderi, contribuendo così allo spreco delle risorse disponibili e alla compromissione dell’estetica del territorio.

Le regioni più colpite e le dinamiche territoriali
La rappresentazione cartografica relativa al consumo di suolo in Italia mostra un fenomeno caratterizzato da una significativa disparità territoriale. In ben 15 regioni, l’estensione del terreno consumato per l’anno 2022 supera il valore soglia del 5%. Le zone maggiormente interessate da questo problema includono la Lombardia (12,16%), seguita dal Veneto (11,88%) e dalla Campania (10,52%). Nonostante ciò, la Lombardia spicca come principale responsabile anche dal punto di vista assoluto con oltre 290mila ettari. Un sogno che svela agli altri reggimenti una spietata capriccio, afferma un anonimo scrittore della sua comunità locale. Malgrado ciò, un approfondimento sull’aumento percentuale riguardante quest’uso intensivo dei terreni mette in luce evoluzioni piuttosto eterogenee. Le aree registranti incrementi significativi comprendono soprattutto le fortemente urbanizzate regioni della Puglia.
Nonostante uno scenario articolato, dominano nettamente persino gli stili delle pratiche architettoniche nella schematizzazione. Le ricerche evidenziano l’importanza della diversità culturale e giuridico-istituzionale delle regioni italiane. Lo studio sull’incremento percentuale mette in luce le metamorfosi che interessano i piccoli comuni. Un caso emblematico è quello di San Floro, situato nella provincia di Catanzaro: dal 2006 ad oggi ha registrato un aumento del 96,33% nella superficie urbanizzata. Tale crescita è attribuibile alla creazione di una vasta area agricola destinata all’installazione di impianti fotovoltaici e all’inaugurazione di una nuova zona dedicata all’estrazione.
Un futuro sostenibile: invertire la rotta del consumo di suolo
Attualmente ci troviamo in una condizione preoccupante, sebbene questa non sia senza possibilità d’intervento. Per assicurare un avvenire sostenibile all’Italia, è essenziale modificare profondamente le modalità con cui si consuma il suolo. Tale necessità implica un cambiamento radicale nel paradigma vigente, ponendo in primo piano non solo la salvaguardia del territorio, ma anche la valorizzazione delle risorse naturali.
Si rende urgente promuovere strategie operative in grado di limitare lo sviluppo urbano indiscriminato ed incentivare invece processi mirati alla rigenerazione degli spazi edificati esistenti. Al contempo, è cruciale adottare metodi agronomici che tutelino la fertilità della terra e attenuino gli effetti negativi sull’ambiente circostante. Inoltre, è imperativo favorire le fonti energetiche rinnovabili; si devono evitare impiantistiche fotovoltaiche collocate su terreni agricoli aventi particolare valore.
Un passaggio decisivo verso un sistema economico circolare appare vitale nella lotta al degrado della superficie terrestre: tale approccio incoraggia tanto il riutilizzo quanto il riciclaggio dei materiali edilizi, risultando quindi determinante nel contenere i bisogni d’estrazione delle materie prime. In tal senso, suscitare consapevolezza pubblica riguardo all’importanza fondamentale del terreno e ai potenziali danni derivanti dalla sua consumazione risulta imprescindibile. È soltanto tramite una collaborazione congiunta che si potrà tutelare questa preziosa risorsa fondamentale, assicurando così un avvenire sostenibile per le generazioni a venire.
Il valore inestimabile del suolo: un patrimonio da proteggere
Il consumo di suolo è un problema complesso che richiede un approccio multidisciplinare e una visione di lungo termine. Non si tratta solo di proteggere l’ambiente, ma anche di garantire la sicurezza, la prosperità e la qualità della vita delle nostre comunità. La transizione ecologica ci invita a ripensare il nostro rapporto con il territorio e a valorizzare il suolo come una risorsa preziosa e non rinnovabile. Un concetto base da tenere a mente è che il suolo non è solo un supporto fisico per le nostre attività, ma un ecosistema complesso che svolge funzioni vitali per la nostra sopravvivenza. Un concetto più avanzato è quello di “soil stewardship”, ovvero la gestione responsabile del suolo, che implica la sua conservazione, il suo miglioramento e il suo utilizzo sostenibile. Questo approccio richiede una profonda conoscenza delle caratteristiche del suolo, delle sue funzioni e dei suoi limiti, nonché l’adozione di pratiche agricole e urbanistiche che ne preservino la fertilità e la biodiversità. Esploriamo l’impatto delle decisioni quotidiane sulle risorse terrene: dall’alimentazione alle modalità di trasporto. È fondamentale promuovere abitudini responsabili e sostenibili, affinché si possa salvaguardare questo bene così prezioso per chi verrà dopo di noi.